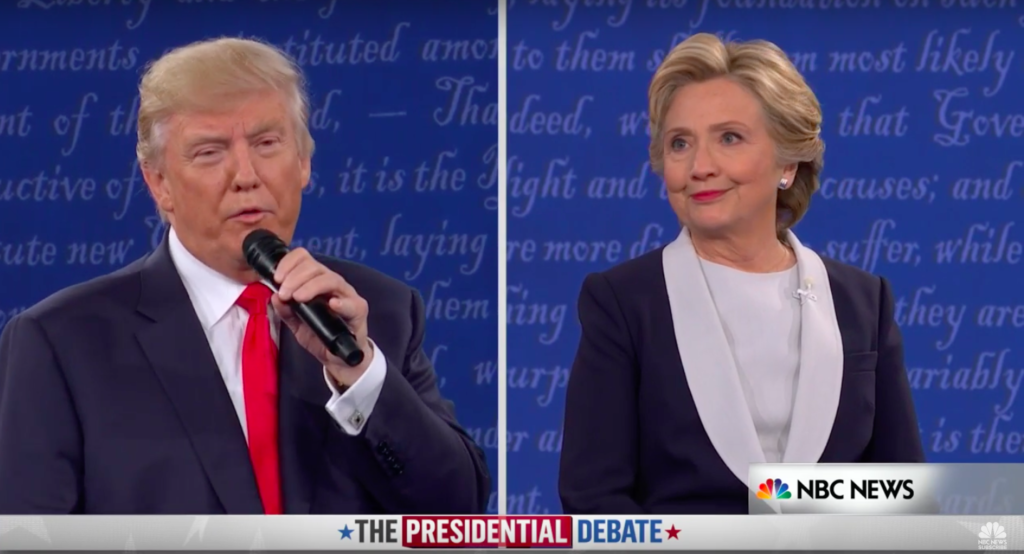Quotidianamente riconosciamo la portata straordinaria delle trasformazioni del modo di vivere, consumare, produrre e lavorare indotte dalle tecnologie digitali. Al punto che, in atto, le definiamo come la quarta rivoluzione industriale. E, rispetto alle tre precedenti, ne individuiamo i caratteri originali della velocità e della imprevedibilità. Paradossalmente, si riscontra invece una certa timidezza a mettere in discussione quel tradizionale, rigido, quadro regolatorio che è stato via via costruito nel tempo della stabilità. Prima di realizzare che il futuro non sarebbe più stato quello di una volta.
Eppure è evidente che il diritto pubblico, ed in particolare il complicato e incerto diritto amministrativo, ci separano dai processi evolutivi dei Paesi con Amministrazioni più flessibili. Così come è evidente che nel Paese con il più grande Partito Comunista dell’Occidente il diritto del lavoro è stato edificato con caratteristiche particolarmente pesanti. Ne è stata controprova la cronica diffidenza degli imprenditori verso il fattore lavoro.
Oggi, lo stesso interrogativo sull’impatto delle nuove tecnologie sulla occupazione, per cui molti temono una polarizzazione delle competenze e dei redditi su pochi privilegiati, può trovare risposte nel segno dell’inclusione solo se non si frappongono ostacoli al pieno accesso di tutti alle innovazioni. E, spesso, il vecchio diritto del lavoro si rivela un impedimento alla piena espressione delle capacità e delle vocazioni di ciascuno perché edificato nel segno dell’omologazione.
Per queste ragioni, con i colleghi Fucksia, medico del lavoro, e Berger, piccolo imprenditore in Alto Adige, ho assunto l’iniziativa di due ddl “sovversivi” del tradizionale impianto giuslavoristico. L’uno contiene deleghe al governo per la redazione di un Testo Unico denominato Statuto dei Lavori, l’altro riguarda la delicatissima materia della salute e sicurezza nel lavoro. Il presupposto delle due iniziative è quindi il venir meno del vecchio mondo, fatto di gerarchie verticali, di mera esecuzione seriale degli ordini impartiti, di predeterminazione rigida della postazione fissa, dell’orario e del salario. Il vecchio mondo su cui è stato costruito tutto il pesantissimo diritto del lavoro. Lo stesso Jobs Act contiene apprezzabili modifiche ma le compensa con definizioni ancor più rigide circa la separazione tra lavoro autonomo e subordinato proprio nel momento in cui la realtà li avvicina.
Alla base dei due ddl si pone una sorta di “salto” metodologico, quello per cui la fonte legislativa, per definizione rigida e perciò incapace di rincorrere i cambiamenti, si deve limitare alle norme fondamentali e inderogabili che sono espressione dei principi costituzionali e comunitari. Per tutto il resto si deve fare rinvio alla duttile contrattazione, soprattutto di prossimità, compresa quella individuale sviluppando la certificazione dei contratti. L’art. 8 della manovra 2011 ha in realtà già segnato questa discontinuità e, non a caso, il governo francese ha recentemente imposto a sindacati fortemente conflittuali un’analoga disciplina. Si tratta ora di estenderne l’uso nella contrattazione e di ampliarne l’applicazione a una parte del salario nazionale come ai contratti individuali attraverso la legge.
La regolazione della salute e sicurezza nel lavoro è per molti aspetti emblematica di quel diritto pesante che si vuole abbandonare senza ridurre i livelli di prevenzione. Anche in questo caso, la riduzione del precetto legislativo ai fondamentali principi comunitari consente la rapida evoluzione di strumenti scientificamente validati come le linee guida, le buone prassi, le norme tecniche. Se il Testo Unico contiene ben 306 articoli e 50 allegati, la nostra proposta si limita a 21 articoli e ad un allegato. Il passaggio dal formalismo giuridico ad un approccio sostanzialista, fatto di formazione insistita, sorveglianza sanitaria di tipo olistico, continuo rinnovamento delle tecnologie, induce più salute. E la certificazione delle professioni esperte può esimere il datore di lavoro da responsabilità garantendo al contempo ambienti di lavoro oggettivamente più sicuri rispetto ai meri adempimenti cartacei.
All’origine di queste proposte sono le visioni di Marco Biagi, la sua diffidenza verso la iperregolazione, la sua intuizione sui cambiamenti dei lavori e sulla fondamentale tutela sostanziale dell’apprendimento continuo. Esse provocheranno discussioni e forse anche le usuali invettive. Con i due colleghi replicheremo pazientemente ai giudizi sommari e saremo aperti a recepire ogni critica costruttiva perché abbiamo inteso soprattutto provocare una riflessione politica e culturale.
Maurizio Sacconi
Intervento pubblicato su Il Sole 24 Ore del 12 ottobre 2016