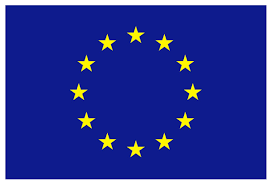Gli scorsi mesi sono stati caratterizzati da un accesso dibattito in merito al contenuto della riforma del Mes (o Esm), il Meccanismo Europeo di Stabilità. A far scaldare gli umori, sarebbe stato il commento di Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, esposto presso il seminario OMFIF in data 15 novembre. Visco, infatti, ha parlato in effetti di «rischi enormi» per il sistema Italia in caso dell’approvazione della riforma. Secondo le opposizioni e molte testate giornalistiche, il commento di Visco delineerebbe una prospettiva drammatica per l’Italia, che si troverebbe a fare i conti con una manovra del tutto sfavorevole e di aiuto alle banche francesi e tedesche. La questione viene portata all’attenzione del vertice di maggioranza del 22 novembre scorso, richiesto a gran voce da M5S. Il vertice si è concluso con un nulla di fatto, lasciando una spaccatura tra PD e M5S. Domenica primo dicembre, un nuovo vertice, stessa storia. Tutto rinviato alle aule parlamentari. Ciò che il governo ha ottenuto al momento è un rinvio dell’approvazione definitiva in seno al Consiglio per questo gennaio. A distanza di mesi, dunque, le acque non sembrano calmarsi. Ma a cosa serve esattamente il Mes, quali critiche che possono essere mosse a questa istituzione?
Il Mes venne costituito per evitare il ripetersi della crisi del debito pubblico che mise in grave difficoltà alcuni Paesi membri dell’Eurozona, i quali avevano dovuto onerosamente coprire le perdite speculative dei rispettivi istituti di credito dell’Unione. Diversi fattori portarono questi paesi (Grecia, Irlanda, Cipro e Portogallo) a trovarsi con un debito pubblico tale da precludere le operazioni di finanziamento necessarie per risolvere la crisi. Il Mes diede, su richiesta dei suddetti paesi, assistenza finanziaria a condizioni a loro favorevoli per ristabilire un rapporto con il mercato obbligazionario. Il caso della Grecia, conclusosi nell’agosto scorso, costituì il più grande pacchetto di assistenza nella storia arrivando a oltre 200 miliardi di euro.
Il Mes storicamente è intervenuto con due funzioni: di finanziamento a paesi insolventi (nei casi sopra menzionati) e di ricapitalizzazione indiretta del settore bancario (nel caso della Spagna). Ci sono altri casi, per ora mai verificatisi, in cui il Mes può entrare in funzione. Il Mes può infatti intervenire per ricapitalizzare un istituto di credito insolvente o con paventata possibilità di insolvenza. Inoltre, può intervenire per creare liquidità nel mercato in caso di difficoltà o paventata difficoltà dell’emittente sovrano di accedere ai mercati. I fondi del Mes provengono dal capitale azionario conferito dagli stati membri (circa 80 miliardi, con una garanzia di aumento di capitale fino a 700 miliardi in caso di necessità) e dalle obbligazioni che emette sul mercato. Chiarito dunque il suo funzionamento, muoviamoci sugli aspetti più controversi.
In cambio di assistenza finanziaria il Mes esige che i paesi richiedenti implementino un pacchetto di riforme che assicurino l’abilità del paese in questione di ripagare l’assistenza ricevuta. Tale pacchetto, viene stabilito dalla commissione europea in collaborazione con la BCE e, ove possibile, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) con il Mes in qualità di partecipante informale. Tuttavia, le condizioni possono essere assai severe, portando, in alcuni casi, lo Stato richiedente assistenza a tagliare la spesa pubblica e gli investimenti strutturali oltre il livello che assicurerebbe una ripresa ottimale di un percorso di crescita. Nel caso della Grecia, basti citare la lettera aperta firmata da economisti del calibro di Thomas Piketty (Paris School of Economics) e Dani Rodrik (Harvard), che criticarono il target del raggiungimento dell’avanzo di bilancio pari al 3.5% del Pil, argomentando che una contrazione della spesa di quel livello avrebbe avuto effetti disastrosi per l’economia e il popolo greco. Tali critiche sono state espresse anche dal FMI, che aveva suggerito, nel caso della Grecia, un target molto più basso del 1.5% del Pil in avanzo di bilancio.
Ma c’è di più. Un altro aspetto problematico del Mes riguarda il suo posizionamento all’esterno del diritto UE, in una posizione “privilegiata” (anche se non interamente slegata) e di difficile controllo da parte dell’Unione. In tal modo, il Mes non rispetterebbe il principio democratico e di accountability degli organi dell’UE. Essendo istituito con un trattato internazionale, infatti, il Mes è sottratto ai meccanismi di controllo delle istituzioni dell’UE, come la Corte dei conti europea e l’accesso ai documenti. Per quanto, come menzionato, le condizioni di accesso ai fondi del Mes siano stabilite dalla Troika coinvolgendo dunque la commissione Europea, è il Consiglio dei Governatori, l’organo apicale di decisione del Mes, ad avere l’ultima parola nel garantire tale accesso allo Stato richiedente. I membri del Consiglio dei Governatori, peraltro, sono i 17 singoli ministri delle finanze dei Paesi aderenti, che non rispondono per la loro responsabilità al Parlamento europeo. Essi sono responsabili unicamente verso i rispettivi parlamenti nazionali. Sono numerosi i pareri contrari alla posizione di autonomia e distanza dal controllo UE del Mes, anche culminate in un una mozione del Parlamento europeo in richiesta di una integrazione dell’istituto all’interno dell’assetto legislativo europeo. Tali riserve, però, sono state rispedite al mittente dal managing director del Mes Klaus Regling, che le ha dichiarate infondate, essendo il Mes legalmente fuori dal quadro normativo europeo.
Oltre a queste considerazioni strutturali, taluni (in primis Visco) rivolgono le proprie critiche alla controversa bozza di riforma del Mes, che si riferisce all’adozione delle cosiddette Collective Action Clauses (CAC). Le CAC stabiliscono che qualora uno Stato europeo dovesse trovarsi in difficoltà, prima di dichiarare il default, si sieda a un tavolo con i suoi principali creditori per rinegoziare il pagamento del debito. La riforma prevede che questi negoziati si possano fare velocemente e con una maggioranza semplice dei creditori (piuttosto che una maggioranza qualificata come nella riforma del 2013, art. 12.3 del Mes). L’effetto delle CAC sullo spread è al centro del dibattito politico in Italia: Visco infatti suggerisce che adottando le CAC il nostro debito diventerà meno appetibile per gli investitori, causando proprio un aumento dello spread.
Solitamente gli economisti riconoscono due effetti che le CAC hanno sullo spread: uno di riduzione e uno di aumento. La riduzione è ottenuta facilitando la coordinazione dei creditori in caso di default, che aumenta la probabilità di recuperare una parte dei fondi prestati attraverso il negoziato; parallelamente le CAC, facilitando il processo della rinegoziazione, aumentano la probabilità che lo Stato decida di rinegoziare, portando, in questo caso, ad aumentare lo spread. Malgrado Visco, pur notando entrambi questi effetti, sostenga che l’effetto di aumento dello spread sia dominante, la letteratura economica non è affatto univoca su questo tema. Nel caso dell’introduzione delle CAC a maggioranza qualificata nel 2013 ad esempio, la Prof.ssa Carletti (Università Bocconi) ha rilevato un significativo effetto negativo sugli spread (di riduzione) soprattutto in paesi fortemente indebitati come l’Italia, abbassando gli oneri degli stati e aumentando la stabilità del sistema finanziario.
Va ricordato poi che l’adozione delle CAC ha l’obiettivo di scoraggiare l’opportunismo dei cosiddetti fondi avvoltoi, i quali comprano porzioni di debito di uno Stato in default con lo scopo di iniziare un procedimento legale per accaparrarsi il valore nominale dei bond più gli interessi. L’obiettivo delle CAC dovrebbe essere quello di proteggere lo Stato da questo tipo di opportunismo una volta che si trova in default. Detto ciò, ci sono altre critiche, più complesse che si possono fare alle CAC stesse; una di queste concerne l’incertezza legale che si crea introducendo queste clausole rispetto al trattamento di debiti sovrani emessi prima dell’introduzione in situazione di default.
Alla luce di queste considerazioni, è certamente corretto stimolare una discussione non solo sui contenuti della riforma, ma su funzionamento del Mes per sé, e sulla possibilità della sua integrazione alla stregua degli altri istituti dell’Unione. Per quanto una misura di politica economica di emergenza comune sia auspicabile, ci ancora molte questioni aperte per quanto riguarda l’assetto normativo in cui opera il Mes e la necessità di implementare un quadro di ristrutturazione del debito. Tuttavia, maggioranza e opposizioni non hanno ancora trovato una posizione definitiva in questo dibattito. Al di là delle questioni di merito, bisogna ricordare che il placet alla riforma è stato dato da un governo gialloverde ormai morente, poco dopo rimpiazzato con il governo attuale. Non sorprende dunque la poca convinzione con cui il Movimento 5 Stelle difende una riforma approvata sotto il loro mandato con la Lega, ormai rinnegato. Di contro, stupisce la scarsa preparazione della classe politica tutta di fronte agli aspetti più problematici (in verità anche i più pacifici) del Mes. Non si può fare a meno di notare che le questioni sollevate dalla politica abbiano travisato il significato del commento di Visco, le cui preoccupazioni, prese nel contesto del discorso integrale, restano valide e meritevoli di ulteriore approfondimento. Il paese resta in attesa della risposta del Parlamento, dove la maggioranza PD-M5S sembra restare divisa, e della approvazione definitiva del disegno in Consiglio. Ciò che è certo è che i malumori dovranno confrontarsi con la natura tecnica della riforma e la giusta considerazione degli interessi in gioco.
Tommaso Di Prospero e Tancredi Rapone