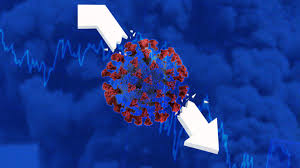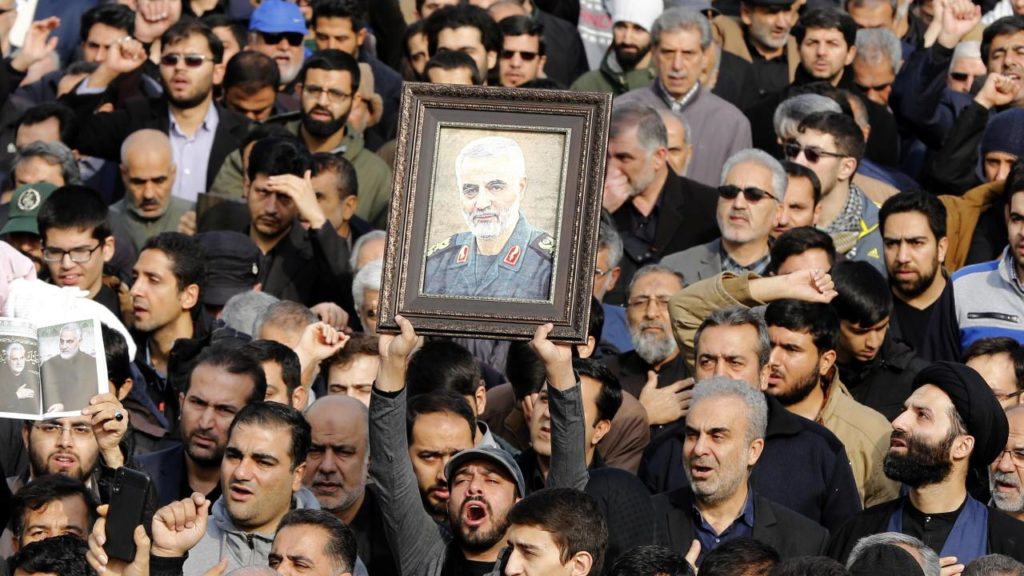di Emanuele Lorenzetti
L’energia è il tema che sta al centro delle sfide poste alla sicurezza internazionale ed è decisivo per l’innovazione e la crescita europea post COVID-19: dai rapporti in Medio Oriente, con focus libico, alla transizione energetica in Europa rappresentata dall’European Green Deal – lanciato l’11 dicembre scorso dalla Commissione UE. La Fondazione De Gasperi ha voluto affrontare il tema con Eni, azienda leader nel settore energetico, attraverso l’analisi di Marco Piredda, Senior Vice President Eni per gli Affari Internazionali.
Dottor Piredda, qual è la situazione del Mediterraneo orientale?
Dal punto di vista energetico, quest’area sta vivendo una centralità senza precedenti. Le importanti scoperte degli ultimi anni hanno catalizzato l’interesse delle compagnie internazionali, con importanti investimenti e una nuova cooperazione energetica transfrontaliera. Pur contando per appena l’1% della produzione mondiale e il 2% delle riserve provate, l’East-Med è diventato l’”hot spot” del gas, con quasi un terzo di tutte le scoperte effettuate dall’industria negli ultimi 10 anni, nonostante le sfide tecniche e geofisiche dell’esplorazione in acque ultra-profonde. Eni è protagonista in questa nuova provincia del gas, con progetti a Cipro, in Libano e, soprattutto in Egitto, dove abbiamo riaperto i giochi con la più grande scoperta a gas mai fatta nel Mediterraneo.
Ma questi grandi sviluppi energetici si inseriscono in un contesto economico e internazionale molto difficile, ulteriormente aggravato dalla crisi causata dal COVID-19. Sarebbe impossibile, in poche righe, richiamare le dinamiche storiche ed i conflitti che segnano ancora questa parte del Mare Nostrum. Tra questi possiamo ricordare, anzitutto, le dispute ancora irrisolte sui confini marittimi (Cipro-Turchia, Libano-Siria e Libano-Israele) che continuano a ostacolare una proficua cooperazione regionale. Inoltre, la questione cipriota, le azioni muscolari di Ankara e la competizione tra le potenze regionali nel Mediterraneo, frenano le prospettive di quella crescita economica che la disponibilità di nuove risorse energetiche potrebbe invece favorire. A ciò si aggiunge un contesto istituzionale e regolatorio eterogeneo e ancora non consolidato.
Ciononostante, il potenziale energetico dell’area – sia per le fonti convenzionali che per quelle rinnovabili – rappresenta un’opportunità per lo sviluppo e la cooperazione regionale, anche con gli stati della sponda nord. La nostra convinzione è che l’energia possa costituire un terreno di dialogo ed un veicolo di stabilità e crescita sostenibile per i popoli dell’intera regione. Senza un sufficiente grado di cooperazione e volontà di condividere rischi e investimenti infrastrutturali, i volumi di risorse che potrebbero essere scoperti resteranno nel sottosuolo, a maggior ragione nell’attuale contesto di mercato che obbliga al taglio dei costi e a privilegiare i progetti più agibili.
Le potenzialità energetiche del bacino del Levante si esplicano, d’altra parte, soprattutto su scala regionale, con una porzione di gran lunga prevalente di idrocarburi che potrà essere consumata nei paesi dell’area: se teniamo in considerazione, da un lato, gli obiettivi europei di neutralità carbonica e, dall’altro, il fabbisogno di gas nel medio periodo di paesi come l’Egitto e la Turchia, è evidente che vinceranno le soluzioni più flessibili, come il GNL, e più vicine ai mercati di sbocco.
L’energia è indispensabile per l’industrializzazione, per la creazione di posti di lavoro, per elevare le condizioni di vita e per avvicinare il nord e il sud del Mediterraneo. La sfida di oggi rimane creare occasioni e spazi di collaborazione, superando contrapposizioni sterili; a tal proposito, l’auspicio è che si consolidi il dialogo strutturato – anche tra rivali storici – che è stato avviato con l’East Med Gas Forum e che vede, tra i membri fondatori, l’Italia e, tra i partner industriali, Eni.
Qui si confermano attuali e preziosi gli insegnamenti e l’esempio di un grande statista come De Gasperi: la visione di lungo periodo per il bene delle generazioni future, il valore della collaborazione anche tra ex nemici, la cultura del pluralismo unita a una forte convinzione religiosa. Penso che la leadership, la lungimiranza e la determinazione di uomini e istituzioni delle due sponde del Mediterraneo sia un ingrediente imprescindibile per lavorare ai grandi obiettivi di sviluppo pacifico e sostenibile, anche attraverso una politica energetica condivisa.
Come vengono valutati – alla luce degli interessi Eni – l’intervento in Libia degli attori esterni e la possibile tripartizione del territorio libico?
Non è un mistero che le interferenze esterne siano oggi il principale nodo della crisi. I flussi di armi e mercenari sono divenuti nuova norma, dunque accettati dai più; inoltre, la molteplice presenza straniera induce a deresponsabilizzare gli attori e le fazioni interne, che dopo aver invocato o favorito questi interventi non paiono più in grado di gestirli o contenerli.
Sul piano energetico la situazione – che appariva sorprendentemente sostenibile fino ad alcuni mesi orsono – sta velocemente degenerando, seppure con importanti differenze tra olio e gas e tra onshore e offshore. Eni è riuscita, grazie a un rapporto privilegiato con i libici, radicato in decenni di collaborazione, a restare e continuare a produrre in questo decennio di guerra civile e divisioni. Nel primo trimestre, le produzioni di petrolio operate da noi o da altri sono rimaste quasi tutte ferme a causa del blocco degli oleodotti e dei terminali di esportazione, con la sola eccezione di pochi campi offshore. Ciò significa, come noto, che sono crollati i flussi finanziari verso la Banca Centrale e che gli investimenti sono fermi. La situazione è parzialmente differente per il gas: la produzione finora è rimasta pressoché stabile, sia in ragione della posizione geografica degli impianti, sia per il ruolo fondamentale che le forniture di gas rivestono per la generazione elettrica e, quindi, i servizi essenziali come illuminazione, climatizzazione, sanità ecc. La gran parte dei volumi di gas che produciamo (circa due terzi) è destinata prioritariamente al consumo interno, con una minore porzione che viene ancora esportata verso l’Italia con il Greenstream.
Questa situazione di squilibrio – con un paese diviso e senza una prospettiva tangibile di pacificazione – non giova a nessuna delle parti, se non forse a qualche attore esterno. Molti libici sono stanchi del peggioramento nelle condizioni di vita quotidiana; ma restano, purtroppo, alcuni grandi e tanti piccoli rais che ancora non rinunciano a una logica binaria, nonostante questa non abbia portato che risultati di corto respiro. Eppure l’aspirazione ideale all’unità ancora resiste tra i libici: tentare di sciogliere i nodi con soluzioni estreme come una tripartizione – del tutto teorica nella sua praticabilità – rischia di essere solo un inutile aggravio e un moltiplicatore dirompente dei problemi già esistenti.
Se esiste ancora una via d’uscita, questa passa per la persuasione degli attori interni, incluse le figure di vertice, che nel gioco a somma zero degli ultimi anni i primi a perdere sono gli stessi libici; poi per un diverso coinvolgimento degli attori internazionali più autorevoli. Il primo riferimento, ovvio, è agli Stati Uniti, che tuttavia non fanno mistero del minore interesse al Mediterraneo centro-occidentale; eppure, condivido la lettura di chi vede il disengagement statunitense come foriero di conseguenze negative per la stessa superpotenza, che in tal modo vede ridursi le capacità di gestire dinamiche regionali e rischi di rilevanza strategica. Alcuni segnali positivi in primavera ci sono stati, resta da vedere quali seguiti porteranno.
L’altro attore essenziale è l’Europa, che nell’azione verso il Mediterraneo incontra certo uno dei propri limiti politici strutturali. Mentre si affronta il dramma sanitario ed economico di questi mesi, converrebbe a noi europei non rinunciare a elaborare e proporre un modello, dare una cifra dell’assetto ritenuto più adatto, accompagnarne l’attuazione: in questa prospettiva, una diversa e più ambiziosa politica di vicinato – ma anche sanzioni applicate puntualmente contro le transazioni di greggio e le forniture di armi non consentite dall’ONU – possono fare la differenza.
In questo quadro, l’energia resta il fulcro dell’economia libica: quanto più si riuscirà ad avvicinare le diverse fazioni intorno al comune interesse a preservare la produzione, tanto più si potranno allontanare gli interessi esterni nocivi e sarà immaginabile una progressiva pacificazione.
Come Eni vuole intraprendere il grande cambiamento alla luce del Green Deal Europeo?
La transizione energetica, che già rappresentava una sfida enorme prima del COVID, oggi potrebbe apparire un’impresa impossibile. Come potremo salvare interi sistemi economici, erosi profondamente dalle ferite di una crisi senza precedenti e, al contempo, modificare i nostri modelli di produzione e di consumo in modo così radicale da contrastare efficacemente il cambiamento climatico? La vostra domanda chiama in causa i due grandi attori che dovranno individuare e costruire le soluzioni per vincere questa difficilissima partita: il mondo delle istituzioni e dei decisori pubblici e il mondo produttivo e delle imprese.
I governi di tutto il mondo sono impegnati ad intervenire con misure straordinarie di stimolo all’economia per rispondere alla recessione. Gli investimenti pubblici, e quelli comunque favoriti dalle misure di stimolo, oltre a permettere la ripresa economica contribuiranno a dare forma ai modelli di produzione e di consumo degli anni a venire. La Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) sta esortando i governi a utilizzare queste leve anche come un’opportunità per consolidare la transizione energetica. Non sarà facile combinare gli sforzi per la ripresa e le modifiche al sistema energetico; ma non abbiamo altra scelta.
Le imprese sono chiamate a ripensare i propri modelli di business e a ridurre l’impatto carbonico con il ricorso a tecnologie e processi innovativi, nonostante la minore disponibilità di risorse. Per quanto riguarda Eni, già nel Piano Strategico 2019-2022 avevamo definito gli obiettivi per contribuire al conseguimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore, fondamentale, passo in avanti con il Piano d’Azione 2020-2023 e il Piano strategico al 2050. Abbiamo confermato e qualificato – con obiettivi di breve, medio e lungo termine – il nostro impegno per coniugare sviluppo e forte riduzione dell’impronta carbonica. Ci siamo impegnati a eliminare, entro il 2050, l’80% delle emissioni dei gas serra dei nostri prodotti (mentre la soglia indicata dall’IEA è del 70%, nello scenario compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi). Mentre saremo impegnati a valorizzare il gas come risorsa di transizione, focalizzeremo la nostra attenzione anche sulle rinnovabili: in questo campo il nostro obiettivo è una progressiva espansione globale, per una capacità installata che al 2050 supererà i 55GW. Ciò che è forse più importante, siamo impegnati a realizzare un cambio di paradigma in tutte le fasi di produzione: le raffinerie europee saranno convertite in impianti “bio”, per la produzione di idrogeno e per il riciclo di materiali di scarto; e abbiamo in cantiere diversi progetti di economia circolare e per la cattura di CO₂. Il nostro plateau di produzione di petrolio è previsto nel 2025, con una componente gas nel portafoglio che crescerà sempre di più (60% al 2030 e circa 85% al 2050).
Eni sta cambiando pelle e intende svolgere un ruolo da protagonista nella transizione, in Europa e nel resto del mondo. In questa difficile fase, con i mercati energetici ai minimi per il “doppio shock” da eccesso di offerta e crollo della domanda, è lecito chiedersi se la forza innovativa dell’industria reggerà l’onda d’urto della crisi e, soprattutto, se i prezzi bassi degli idrocarburi rallenteranno la diffusione delle fonti rinnovabili, ritardando la transizione. È probabile che vedremo molte correzioni di rotta, riorganizzazioni e trasformazione dei modelli di business. Eni potrà contare sulla propria capacità finanziaria e tecnologica, oltre che sulla sua proiezione internazionale e sulla forza delle persone che ci hanno permesso di superare altri frangenti difficili.
Secondo molti, ciò che finora è mancato e che rischia di compromettere la lotta al cambiamento climatico è il governo di questo processo, che ha mille implicazioni politiche, finanziarie, tecnologiche e sociali: la transizione richiede una guida da parte dei governi e delle organizzazioni internazionali ma, soprattutto, delle grandi potenze economiche globali. Il “Green Deal” europeo prevede un percorso per una transizione sostenibile e socialmente equa; noi condividiamo questi obiettivi di fondo e saremo in prima linea per assicurare il loro raggiungimento. Ma le emissioni europee sono una piccola porzione (meno del 10%) di quelle globali: anche se confermassimo la nostra leadership nella sostenibilità ambientale, purtroppo ciò non basterebbe. Siamo, quindi, di fronte a una doppia, formidabile, prova. Da un lato, completare la grande trasformazione del sistema energetico e produttivo europeo per fare dell’eccellenza ambientale un punto di forza e un volano di sviluppo, evitando – anche con il ricorso a misure tariffarie – la concorrenza asimmetrica di altri sistemi economici. Dall’altro, promuovere con tutta la forza ideale e diplomatica di cui saremo capaci l’adozione di decisioni vincolanti a livello internazionale, tali da fornire indicazioni attendibili e di lungo periodo agli attori economici, ma anche la realizzazione di parternariati regionali e settoriali con le aree meno sviluppate, in particolare l’Africa.